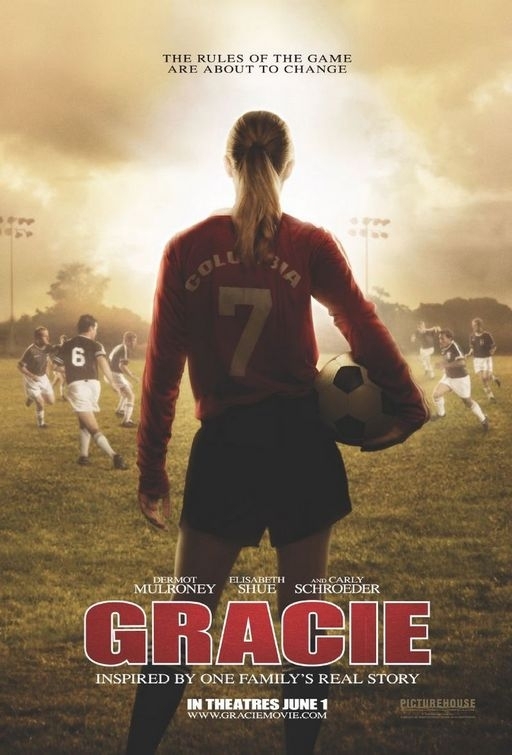Amanti del genere, riunitevi, ma senza eccessiva fretta.
Un titolo che merita la contenuta attenzione degli appassionati di horror, sezione ‘bambini posseduti’, è senz’altro Joshua. Il sentiero battuto da Omen – Il presagio viene qui ripercorso con uno stile ancor più inquietante, introspettivo, disturbato.
I Cain sono una famiglia come tante: newyorkesi, borghesi, stressati, depressi. Nella loro normalità spicca però la figura enigmatica del figlio, Joshua per l’appunto, un bambino precoce, arguto, un piccolo genio. Quando viene alla luce la secondogenita in casa Cain gli equilibri, già precari, si spezzano e si tramutano in squilibri, alimentando una spirale inquieta di eventi.

La pellicola, pur non giovando di picchi emozionali eccessivi, s’inserisce con dimestichezza all’interno del filone sopraccitato. Il progetto riscuote in fase di distribuzione la buona vena delle assennate scelte pre-produttive. In primis l’ambientazione, svoltasi maggiormente all’interno dell’impersonale appartamento dell’Upper East Side di Manhattan, ha donato al film quella ‘cappa’ narrativa, indispensabile per costruire un incalzante climax d’inquietudine ed angoscia. La chiusura dell’appartamento e la conseguente ermeticità sociale della famiglia contribuiscono all’enfasi emozionale, quasi stringendo il cerchio intorno ai già ristretti Cain. Kubrick’s Shining docet.

Un altro punto a favore è senz’altro la scelta del cast: un ottimo, come sempre, Sam Rockwell è un padre stranamente affettuoso, un’intensa Vera Farmiga, già vista nei panni di una femme fatale sui generis in The Departed di Scorsese, assume connotati bipolari davvero ben ritmati. Sorprendente poi l’interpretazione di Jacob Kogan, accompagnato dall’ormai insopportabile slogan affibbiato ad ogni debutto (con successo) infantile: “per la prima volta sul grande schermo”, il quale investe Joshua di una profondità e di una subdola irrequietezza che, in alcuni momenti, sembra addirittura travalicare le intenzioni narrative dello script dello stesso regista George Ratliff. Il quale (lo script) è croce e delizia dell’intera pellicola. Se, infatti, da una parte ci regala un drappello di personaggi davvero ben strutturati, dall’altra ci butta lì un finale davvero poco entusiasmante. Crea tutte le aspettative del caso, ma poi le disattende proprio nella fase di maggior carica emotiva della narrazione.

A conti fatti, in un panorama di desolazione, di qualità e quantità, distributiva, Joshua è senz’altro un prodotto interessante. Con tutti i limiti del caso, finirà per essere il miglior horror, psicologico più che fisico, della stagione estiva.
Curiosità in calce, non inserita a tempo debito per l’eccessivo rischio di distrazione riscontrato nei più accaniti fan: Jacob Kogan vestirà i (pesanti) panni dell’umano/vulcaniano Mr.Spock adolescente nell’attesissimo Star Trek firmato dal moderno guru del mistero, J.J. Abrams.
VOTO 65/100
Tommaso Ranchino